L’aspetto storico e sociale è ciò che mi interessa maggiormente del Cibo, come mutano piatti e abitudini nel tempo, l’origine degli ingredienti e delle usanze. Uno tra quelli che considero i mali peggiori della retorica del food – che altro non è che il gossip intorno al Cibo – è la mitizzazione acritica del passato. Un passato descritto come glorioso e dove tutto era più buono e genuino, una stupenda fiaba per credenti che scorre in tempo cristallizzato che non conosce mutamenti. Ne sono esempi lampanti i linciaggi sui social verso chi reinterpreta a modo suo piatti della tradizione portando in dote argomentazioni che fanno capo a disciplinari recenti e moderni. Sono crociate spesso condotte da chi usa la parola “tradizione” per imporre le proprie convinzioni sugli altri.
La Tradizione, con la T maiuscola, è piuttosto una continua stratificazione e aggiornamento basata sull’importazione di ingredienti e piatti rielaborati a seconda delle esigenze del momento o del luogo. Ad esempio, la pasta alla carbonara che mangiamo oggi, difesa a spada tratta da una mandria di chef, giornalisti e blogger in cerca di applausi ma con poca cognizione di causa, è “invenzione” recente, sicuramente distante anni luce dalla sua forma originale. La Tradizione è una lingua in perenne mutazione, che si libera di ciò che diventa obsoleto, che accoglie nuovi ingredienti e metodi di cottura e, di conseguenza, piatti. Ogni piatto è un meticcio di secoli stratificati.
Uscire da questo tossico confronto tra tifoserie è necessario, soprattutto in tempi di crisi come quelli che ci accingiamo a vivere, in cui è richiesta più capacità di mediazione e trattativa. E iniziare da una cosa così “banale” come il Cibo è un buon punto di partenza per strapparci di dosso stereotipi, diffidenze e superstizioni, anche lontano dalla tavola.
La fame aguzza l’ingegno di Andrea Perin è un libriccino (140 pagine effettive) che dà molti spunti di riflessione e confronto, nonché nozioni per rivalutare la nostra (errata) concezione di tradizione storicizzata, fissa in un monolite inscalfibile.
Perin, che è un architetto museografo con la passione per la gastronomia, riesuma ricettari della Prima Guerra Mondiale per fotografare una cucina molto lontana dalla retorica di chef a caccia di slogan per vendere una cena nel proprio ristorante o qualche copia del proprio libro. La cucina della nonna, in pratica, non esiste ed è confusa con la cucina dei giorni di rito. Tanti piatti tanto osannati dalla fiaba culinaria contemporanea sarebbero indigesti per i nostri stomaci. La carne era ingrediente pregiato che ci si poteva permettere di rado e solo chi poteva ammazzare una bestia la mangiava fresca ma solo per poche settimane (non c’erano frigoriferi, arrivati col boom economico degli anni Cinquanta) per poi consumare gli stagionati. Brasati e bolliti compaiono solo nelle feste comandate. Nel resto dell’anno scorre una cucina d’emergenza fatta di costante salvataggio di ciò che poteva essere ancora commestibile, anche cose che noi oggi getteremmo nell’umido senza troppi patemi. Le tavole dei contadini non avevano lo sfarzo delle mense padronali.
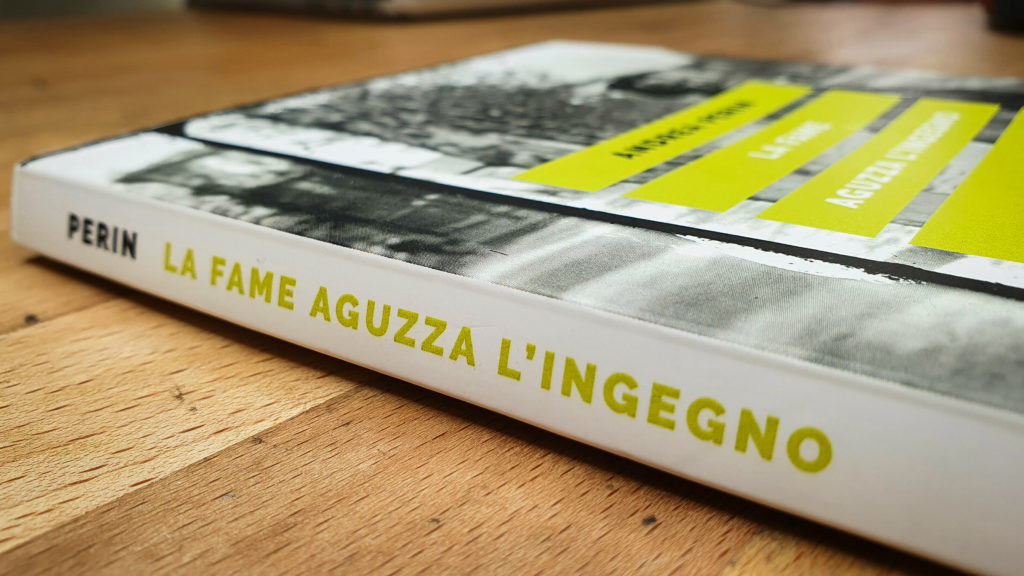 Il libro, dopo un’interessante introduzione in cui non mancano punzecchiature alla strumentalizzazione che la politica fa della tradizione gastronomica, è diviso in piccoli capitoli tematici (primi, verdure, carne, pesce, animali da cortile, pane, dolci) con ricette e commenti e aneddoti storici dell’autore, che ha riprodotto in casa molti dei piatti.
Il libro, dopo un’interessante introduzione in cui non mancano punzecchiature alla strumentalizzazione che la politica fa della tradizione gastronomica, è diviso in piccoli capitoli tematici (primi, verdure, carne, pesce, animali da cortile, pane, dolci) con ricette e commenti e aneddoti storici dell’autore, che ha riprodotto in casa molti dei piatti.
L’autore sottolinea più volte come, fino a prima dell’avvento del boom economico, la suddivisione di classe dei cibi fosse netta e a tratti impenetrabile. Solo il “benessere” ha abbattuto quella barriera sedimentata nei secoli. È anche per questo che compaiono piatti con “surrogati”, ovvero alternative povere a materia prima pregiata. I dolci non hanno creme e sono poco zuccherati (almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale lo zucchero era roba esclusiva dei ricchi) ma sono impasti compatti di patate, mais, non solo grano. Non mancano piatti che richiamano l’idea classica dell’uso degli scarti (le bucce dei piselli, ad esempio). Spesso mancano le uova perché si mangiavano solo nelle poche settimane dell’anno in cui le galline covavano (c’è una “frittata senza uova” fatta con le patate). Ogni capitolo è chiuso da una breve scheda di approfondimento su un tema pertinente.
Non lesinando critiche al teatro dei grandi chef e dei foodblogger, nonché alla costante e morbosa spettacolarizzazione del cibo fine a sé stessa, Perin attacca anche i movimenti come Slow Food che predica nobili ma scollegati dalla realtà in virtù di una supposta superiorità etico-morale e che non tiene conto concretamente delle contraddizioni di un sistema-mondo, sebbene si prefigga di combatterle.
Si può essere o meno d’accordo con le tesi a supporto ma sicuramente Perin tratteggia uno scenario molto distante dalla narrazione melensa del “prima era meglio” (nelle case non c’era nemmeno acqua corrente pulita, giusto per sottolineare una cosa che oggi ci appare ovvia) e invita a un approccio critico verso la cucina, che non vuol dire diventare raffinati recensori bensì Gastronomi nel vero senso della parola, portatori di un bagaglio culturale che ci induce a porci sempre delle domande per comprendere, non solo ciò che mangiamo ma il mondo con cui ciò che mangiamo è connesso e a toglierci di torno questo continuo sciame di pernacchie dello squadrone dei Defenderz Of Tradizioneh che, e parlo a titolo personale, sono la peggior catastrofe abbattutasi sul Cibo grazie ai social.
